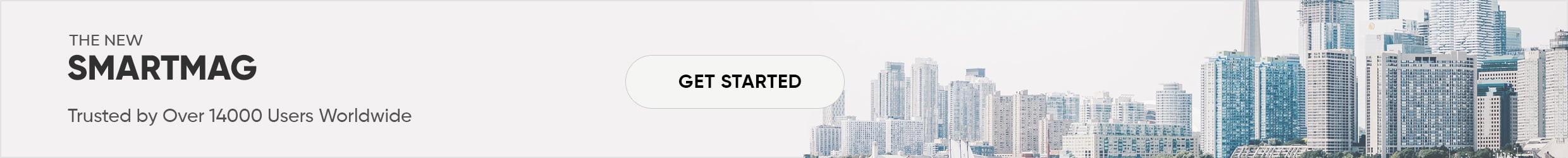“Il diritto non è una spada, ma un argine.”
Con queste parole, pronunciate dai giuristi dell’epoca, si può riassumere lo spirito che animò il processo di Norimberga, iniziato il 20 novembre 1945. Ottant’anni dopo, quel tribunale non è soltanto un capitolo di storia: è un richiamo ancora vibrante alla responsabilità degli uomini e degli Stati.
Fu lì, in una Germania sconfitta e in macerie, che per la prima volta la comunità internazionale decise che un crimine poteva essere così grave da trascendere i confini nazionali. I leader del Terzo Reich (Göring, Hess, Ribbentrop e altri) vennero giudicati non dai vincitori, ma da una Corte che voleva affermare un principio nuovo: non esiste obbedienza che possa giustificare l’orrore, non esiste guerra che renda lecito il disumano.
Quel processo cambiò la storia. Gettò le basi per il diritto penale internazionale, per la definizione di genocidio, per ciò che oggi chiamiamo “crimini contro l’umanità”. Ma soprattutto restituì dignità alle vittime, inaugurando una stagione in cui, per un momento, il mondo credette davvero che la giustizia potesse essere universale.
In un mondo segnato da guerre che sembrano non conoscere fine, da civili colpiti senza distinzione, da Stati che sfidano apertamente il diritto internazionale, l’eredità di Norimberga appare più fragile che mai.
Ottant’anni dopo, quindi, la domanda che incombe è inevitabile: quanto di quello spirito sopravvive nel nostro tempo?
di Matteo Peretti